Faya Dayi – Recensione senza spoiler – Il cinema di cui l’Occidente ha bisogno

Faya Dayi – Recensione
C’è una bellezza straordinaria in Faya Dayi, in questo lungometraggio di Jessica Beshir, una regista etiope-messicana che è riuscita nel difficile intento di trasmettere la poesia ricca di contraddizioni di questa terra, un luogo odiato dai suoi stessi abitanti eppure gremito di sconfinata ricchezza. La ricchezza spirituale e umana di un popolo a cavallo tra tradizione e innovazione; un popolo che vuole dimenticare se stesso, ma che non riesce a dire addio per sempre al suo passato.
Impresa non da poco è trovare un corrispettivo di questo film adesso, nel periodo storico che stiamo vivendo oppure in passato, e altrettanto difficile è fare una recensione che si basi sui criteri che siamo soliti utilizzare per capire se un film è apprezzabile o meno. Non è possibile misurare un’opera del genere con il nostro metro, conteggiando ogni centimetro di un abito che non abbiamo mai visto nelle nostre vetrine. Bisogna solo lasciarsi trasportare dalla sua lentezza, dall’uso del bianco e nero, dalla potenza delle sue immagini. E assistere senza alcun pregiudizio alla storia di questo ragazzo che si vede correre nell’acqua a inizio film e alle vicende di un intero popolo, dedito a lavorare la terra con in sottofondo preghiere antiche e canti di straordinario mistero.
Faya Dayi – L’importanza dell’acqua e della terra
Per tutta la durata di questo lungometraggio, ricorrono sempre la terra e l’acqua. Ad inizio film, si vede questo ragazzo correre, sgambettare in acqua, e tanti lavoratori d’ogni età lavorare, zappare, vivere a contatto con la terra. Provano un rispetto e una devozione quasi religiosa nei confronti di questi imprescindibili elementi naturali, e onorano la loro presenza con canti e preghiere rituali. L’Etiopia viene cantata attraverso le sue montagne e i suoi fiumi, ma soprattutto attraverso il racconto di una pianta, il khat, che fornisce al popolo sostentamento e che viene esportata e venduta in tutto il mondo. Le vicende umane di tanti personaggi si mescolano al raccolto di questa pianta e alla fatica di una vita trascorsa a lavorare. Il racconto è lento, scorre placido come l’acqua etiope, nella quale ci si immerge fino al collo, nella quale si gioca, ci si bagna, si ritrovano le energie per poter riprendere a lavorare, in questa incessante eppure agognata schiavitù, cui molti decidono di sottrarsi alla ricerca di una vita migliore.
Sono in molti, infatti, a lasciare questa terra e a recarsi in Europa, ma poco dopo tornano, seppur controvoglia, per lavorare e per aiutare le famiglie. Il film, che si presenta come una sorta di documentario, racconta anche questo aspetto della vita, non tralasciando la malinconia di chi torna e di chi resta, il rapporto conflittuale che ognuno ha con la patria. Una terra che non permette ai suoi abitanti di vivere degnamente, che li condanna a giorni sempre uguali, ma che serba allo stesso tempo una poesia che è impossibile rinvenire altrove.
Faya Dayi – L’uso del bianco e nero
Jessica Beshir racconta la sua storia, attraverso le vite dei suoi personaggi. Racconta di quando, da ragazza, è stata costretta ad abbandonare la sua terra natale di Harar per ragioni politiche. Poco più che adolescente, insieme alla sua famiglia, dice addio ad un mondo che aveva imparato ad amare, per poi farne ritorno molto più tardi. Ha ritrovato quello stesso mondo che aveva lasciato, cristallizzato nel tempo, rurale e antico, subendone l’intramontabile fascino. Eppure, avverte che ha perso quello spirito, che qualcosa in lei è inevitabilmente mutato. Tale scarto le consente di vedere che al di là della coltre di nebbia e di raccontare l’orrore che può celarsi al di là del carattere mitico del racconto, dei personaggi, di questo mondo tanto distante dal nostro. Così Beshir solleva con il suo tono delicato la drammatica questione della droga. Il khat, dapprima citato, è una pianta che dà euforia e che viene coltivata e venduta da questo popolo. Un elemento che non appare chiaro allo spettatore, finché non ne comprende il dramma, il modo in cui influisce sui personaggi, come cambia i suoi abitanti.
Il tutto si mescola, attraverso l’uso del bianco e nero, rappresentando le luci e le ombre di vite meravigliose confinate ai margini del progresso, la bellezza di chi è dimenticato ed è costretto a dimenticare. Il rimo della narrazione è lento, dolce e docile al contempo, come quello di un carezzevole canto con cui si apre il film. Un canto rivolto all’amata terra e agli dei. Faya Dayi impartisce così una lezione di cinema e di vita agli occidentali sulla necessità di rallentare, di concedersi il lusso di fermarsi al sole e respirare. Di tornare indietro ad un altro modo di fare cinema, senza troppi orpelli o effetti speciali. Di guardare senza pregiudizio ad un mondo ricco di simboli, di spiritualità e ad una vita tanto distante da essere quasi irraggiungibile, ma che ci può aprire molte porte, molte strade. Il film, che sarà disponibile in esclusiva su Mubi a partire dal 10 agosto, è un viaggio imperdibile in noi stessi. Un film di rara bellezza e poesia, che sarebbe un vero delitto perdersi.










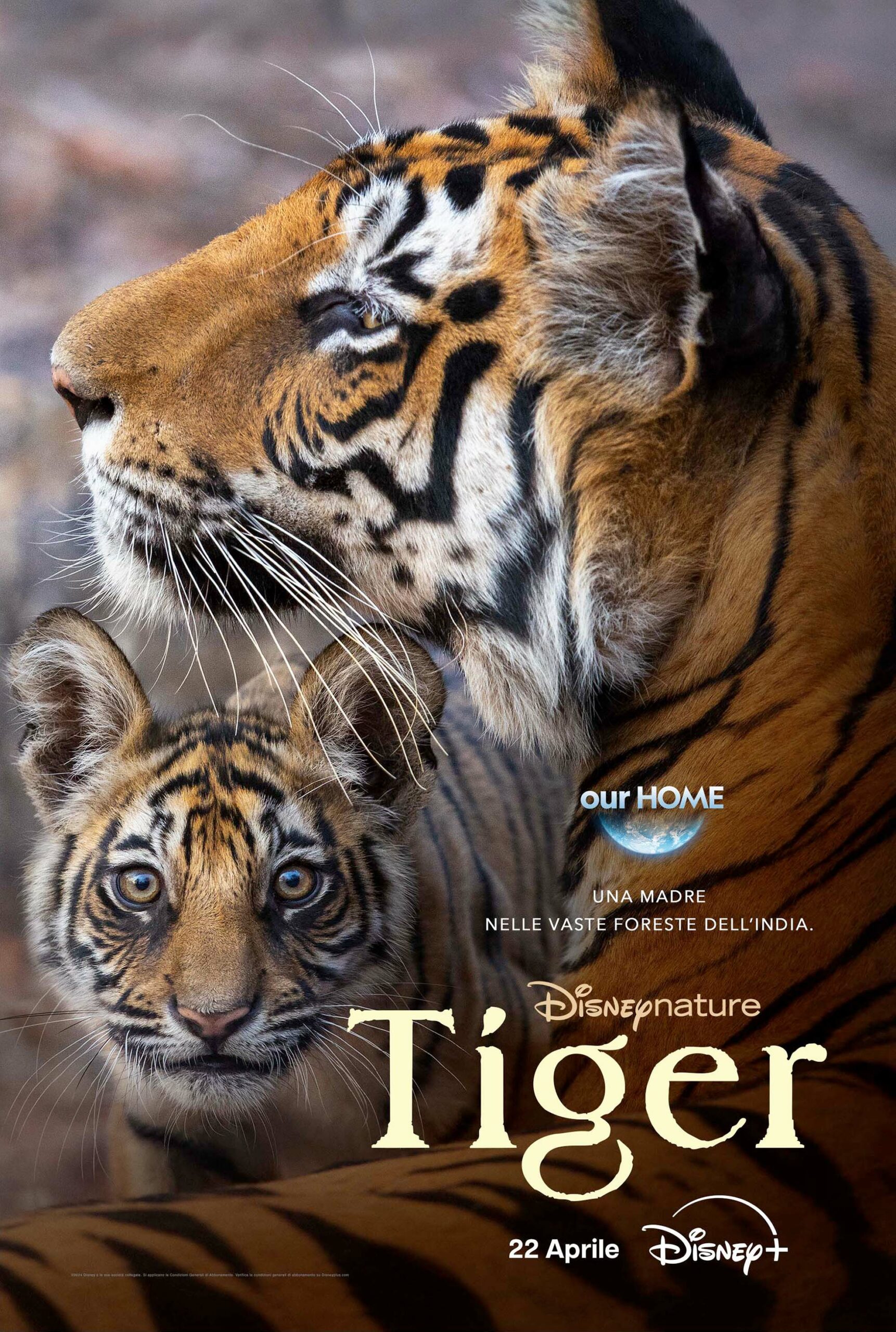








Vota o Commenta